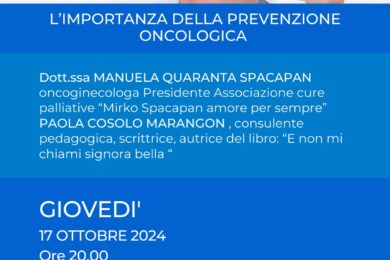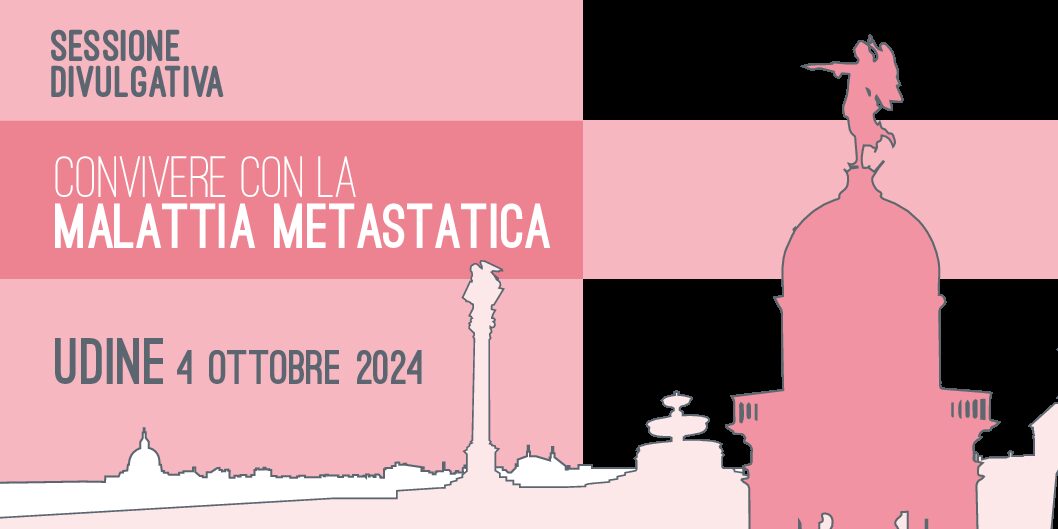intervista a Laura Campanello. Se vuoi vivere, impara a morire

Tentiamo in tutti i modi di non pensarci, la verità è che prima o poi dovremo fare i conti con la morte. La nostra o quella delle persone che ci sono care. Per l’analista filosofa, consulente pedagogica e formatrice che lavora da anni a fianco dei malati terminali e delle loro famiglie, essere consapevoli della nostra mortalità è un modo, forse l’unico, per vivere pienamente tutto il tempo che ci è concesso.
Ti ho sentito dire più volte che noi siamo piuttosto analfabeti nel parlare della morte. In cosa consiste questa ignoranza?
Da un lato la morte è ostentata in tutti i modi, ma è negata nei nostri discorsi più autentici e più intimi. Non abbiamo più la capacità di stare in questo argomento e quindi di trovare le parole, le posture, i gesti, il silenzio che competono invece a temi così importanti e che ci riguardano tutti. È un analfabetismo dato dal fatto che siamo scappati da una cornice, da un contesto che ci ha lasciati senza parole, ritmi, riti, gesti e quindi proviamo un grande imbarazzo nel parlarne, rischiamo di dire le parole sbagliate o di scappare per paura di essere in qualche modo contagiati da qualcosa che ci terrorizza.
Perché è importante diventare consapevoli del fatto che un giorno non ci saremo più?
Perché è l’unico modo per vivere in maniera vera e intensa il tempo che abbiamo, le relazioni che viviamo, è il modo per radicarsi senza pensare sempre che la felicità, il destino o quello che vogliamo essere si manifesterà in un futuro indefinito. Aiuta a vivere il tempo presente, a rendersi conto che ogni momento è speciale, unico e irripetibile, altrimenti viviamo come eterni e questo non ci permette di esistere appieno.
Hai lavorato per dieci anni presso l’Hospice V. Floriani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano come assistente spirituale laica, ora ricopri lo stesso ruolo nella RsA Villa dei Cedri di Merate. Cosa fa di preciso una filosofa in ospedale?
Aiuta il paziente a tenere una cornice di senso rispetto a quelli che sono gli interventi terapeutici, soprattuto in merito alle scelte che deve prendere con la sua famiglia sulla qualità della vita, sul significato che dà alla fase finale o comunque alla malattia dove necessariamente vengono rivisti i valori di riferimento, per esempio i concetti di destino, di felicità, di libertà. Tutto viene rimesso in discussione e questo richiede in maniera forte la necessità di un nuovo senso che si declina in scelte terapeutiche, in scelte sul dove morire, come morire, con chi morire che sono evidentemente molto forti e che non trovano quasi mai risposte nella medicina o comunque in chi è abituato a curare il corpo e non lo spirito.
La filosofia ti aiuta a capire che l’inquietudine fa parte della vita, che non a tutto c’è una risposta, che a volte saper stare in quella fatica che sono la malattia, la morte, il non senso aiuta a cambiare sguardo sull’esistenza.
Come può la filosofia aiutare a elaborare il lutto per la morte di una persona cara?
Tenta di inserirlo in una cornice di fisiologia e non di patologia, aiuta a recuperare la morte come un evento della vita, un evento universale. Ti aiuta a recuperare quello che hai vissuto con la persona cara, perché questo ti aiuta a lasciarla andare conservandola nel ricordo; ti aiuta a vedere più quello che hai vissuto rispetto a quello che, inevitabilmente, hai perso. Cerca di riportare la morte, ma ovviamente questo lo fa anche la psicologia, su un piano della realtà dell’essere umano e non a viverla come una sventura che è toccata a te e a nessun altro. Aiuta a riflettere sulla condizione umana perché il dolore va attraversato; questo la filosofia lo sa. Anche costatare che un pensiero millenario come quello filosofico abbia tentato da sempre di dare delle risposte al dolore e alla morte in qualche modo aiuta.
Perché in questi casi c’è bisogno proprio del filosofo e non dello psicologo?
La filosofia ti aiuta a capire che l’inquietudine fa parte della vita, che non a tutto c’è una risposta, che a volte saper stare in quella fatica che sono la malattia, la morte, il non senso aiuta a cambiare sguardo sull’esistenza. Lo psicologo spesso e volentieri tende a pensare di dover trovare delle risposte e di dover aiutare la persona a ritrovare delle risorse che la portino fuori dalla crisi; tende a mantenere lo sguardo dei medici e della società e cioè che non bisogna soffrire, che non bisogna essere consapevoli della morte, che non bisogna deprimersi. A molte persone questa modalità non corrisponde e poi molti dicono: “io sto morendo, non ho bisogno dello psicologo”. Anche se non ci piace più vederle come tali molte fasi della vita come la malattia, la morte, il lutto sono estremamente fisiologiche. Le persone lo intuiscono e l’approccio del filosofo (quantomeno del mio) è proprio quello di stare nella fatica di una domanda dalla quale solo nel tempo emerge una risposta, ma che non può essere la risposta dell’ottimismo o di una falsa speranza o di un “facciamo finta che andrà tutto bene” perché non è vero, purtroppo. In certi casi non avere risposte è universale e umano.
Cosa ti hanno insegnato in dieci anni i malati terminali con cui ti sei confrontata?
Fondamentalmente a stare al mondo, a capire cosa conta davvero e quanto è importante rendersi conto che siamo tutti malati terminali, da sempre. Non dobbiamo aspettare di essere in un letto e avere dieci giorni di vita per capire come è importante fare un bilancio, un rilancio, dire alle persone care le cose belle. Ho imparato, come Heiddeger e molti altri da sempre ci dicono, che dovremmo vivere un po’ di più come accompagnati dalla dimensione della morte. Siamo tutti drammaticamente terminali e solo quando ce ne accorgiamo iniziamo a vivere. C’è una frase bellissima che avevo trovato e che appartiene a Confucio: “Abbiamo due vite, la seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola”. I malati terminali ti insegnano a capire che questa è l’unica vita che hai e la devi vivere.
Per tentare di superare il tabù della morte, tu organizzi dei Death Cafè dove discutere liberamente di tutti gli aspetti relativi al fine vita. Come ti è venuta l’idea di organizzare il primo incontro?
L’ho fatto perché avevo letto che nel mondo anglosassone è un’idea già consolidata, ma anche perché facendo in giro tante conferenze, lavorando anche come formatrice su questo tema, ho visto che moltissime persone mi dicono che sarebbe bellissimo poterne parlarne più spesso e più liberamente. Effettivamente poter discutere più liberamente della morte in realtà ti permette di parlare profondamente della vita, perché tu parli della morte, ma è un pretesto per parlare di aspetti dell’esistenza che altrimenti rischi di tacere o di negare. Ho deciso di provare ed è stato un grandissimo successo. L’incontro è stato organizzato alla “La Cicala” di Merate, una libreria che conta 40 posti eppure eravamo una settantina, erano tutti entusiasti all’idea di farlo e desiderosi di farlo più spesso. Il prossimo incontro è stato organizzato alla fine di gennaio, sempre lì.
Su questo argomento hai scritto ben tre libri, di cui uno tratto dalla tesi scritta per la Specializzazione in Consulenza Pedagogica e Ricerca Educativa: Non Ci lasceremo mai? L’esercizio filosofico della morte tra autobiografia e filosofia; Sono vivo ed è solo l’inizio e Leggerezza. Come mai tutta questa attenzione al tema della morte?
È un tema che mi ha sempre toccato a livello personale, questo lo racconto in quella che è la mia tesi e che poi è diventato il mio primo libro, nasce dal confronto con quella che è stata da sempre una grossa paura che per me c’è sempre stata fin da bambina; questa attenzione è nata davvero come un’esplorazione a una paura molto personale, così quando ho incontrato Romano Madera che proponeva l’esercizio filosofico della morte come tentativo di pacificazione con questa dimensione l’ho trovata la soluzione a tutti i miei mali.
Sui social condividiamo delle gran maschere, tante cose più o meno superficiali, ma nel momento in cui entri nella parte più autentica della vita c’è una sorta di sacralità di cui tener conto.
Tu hai partecipato come consulente al lancio di un oggetto virtuale particolare, il Life Deposit Box (LDB): una scatola segreta, protetta e organizzata per contenuti. Possiamo considerarlo un testamento multimediale?
Sì, ma prima ancora è una scusa per fare l’esercizio autobiografico di selezionare i propri ricordi, di recuperare parti importanti di sé, di pensare alle persone care, di vedere che cosa gli si lascerebbe e soprattutto di fare i conti con il fatto che se io dovessi morire domani ho già predisposto tutto. Noi tendiamo sempre a immaginare che ci sarà un tempo in cui fare queste cose, ma in realtà non lo sappiamo.
Lo slogan del LDB è “Don’t share”. Perché chiedi esplicitamente, in una società dove si condivide ogni fatto privato sui social, di non condividere il contenuto della scatola?
Proprio perché è un esercizio di scavo autobiografico, di quelli che sono i propri significati del vivere ed eventualmente anche del morire, devi poter scegliere con chi condividere questi aspetti. Sui social condividiamo delle gran maschere, tante cose più o meno superficiali, ma nel momento in cui entri nella parte più autentica della vita c’è una sorta di sacralità di cui tener conto. Non è una cosa da piazza, è una cosa da piccola stanza di monastero. È questo che la rende preziosa.
.
•